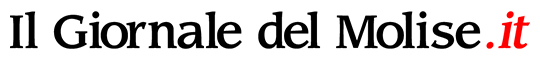di Italo Di Sabato*
Il 22 gennaio, nella sede dell’ANCI a Roma, si è riunita la Consulta delle città capoluogo per discutere di sicurezza urbana. Tra i presenti anche la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte. L’esito dell’incontro, al netto delle formule di rito, è stato fin troppo prevedibile: tutti a chiedere più polizia locale, più strumenti repressivi, più videosorveglianza. Nessuno – o quasi – a parlare seriamente di prevenzione.

Le richieste avanzate dai sindaci sono chiare: una collaborazione più stretta con il Governo per contrastare violenza giovanile, microcriminalità e marginalità; rifinanziare un Fondo per la sicurezza urbana fermo a 25 milioni di euro; colmare la carenza di organico della polizia locale, con 11.400 agenti “mancanti” negli ultimi undici anni; sbloccare l’accesso ai dati e l’interoperabilità; aggiornare sistemi di videosorveglianza e strumenti tecnologici. Il presidente ANCI Manfredi ha ricordato che la sicurezza è competenza dello Stato e che servono almeno 11mila agenti in più. La sindaca Forte ha ribadito che anche i capoluoghi medio-piccoli vivono criticità reali e che senza risorse e strumenti adeguati i Comuni non possono sostituirsi allo Stato.
Tutto vero, in parte. Ma è proprio qui che si annida il problema politico: questa idea di sicurezza è monca, miope, e finisce per produrre esattamente l’opposto di ciò che promette. Alimenta l’insicurezza percepita, non riduce quella reale.
Un governo locale serio dovrebbe agire come un bravo pianista: suonare con dieci dita, con orecchie e occhi ben aperti. Perché i malesseri che attraversano una città non sono mai “problemi di sicurezza” in sé. Sono problemi economici, sociali, sanitari, culturali. Diventano problemi di sicurezza solo quando non vengono affrontati per tempo, con strumenti adeguati, efficaci e coordinati.
Il governo della città non può essere ridotto a una filiera repressiva. Deve invece saper mettere in sinergia servizi sociali, sanità, Asrem, ispettorati del lavoro, scuole, università, aziende pubbliche, polizia locale e nazionale, vigili del fuoco, associazioni di volontariato, sindacati, parrocchie, realtà sportive e culturali. Nessuno di questi attori, da solo, può risolvere i problemi. Ma tutti insieme possono prevenirli.
Il primo slogan di ogni amministrazione dovrebbe essere uno solo: prevenzione. Non come parola vuota, ma come pratica quotidiana.
Prendiamo il tema delle tossicodipendenze. Se oggi molte persone dipendenti da sostanze finiscono per vivere in strada e diventare talvolta moleste, non è perché manca la polizia. È perché i SERT sono stati smantellati o ridotti a sportelli di distribuzione del metadone; perché non esistono più servizi socio-sanitari capaci di prendere in carico le persone, accompagnarle in percorsi terapeutici e di reinserimento sociale e lavorativo; perché non esistono servizi di strada. L’assenza di prevenzione trasforma un problema sanitario e sociale in un problema di ordine pubblico. E quando la risposta diventa repressiva, il risultato è sotto gli occhi di tutti: circa il 35% dei detenuti nelle carceri italiane è tossicodipendente. Il carcere non cura, non reinserisce, non risolve. Produce recidiva, moltiplica il problema.
Lo stesso vale per il disagio psichico. Se oggi nelle carceri aumentano i “matti”, è perché i servizi territoriali di salute mentale sono stati desertificati. Le persone con sofferenza psichica, lasciate sole, finiscono per strada, compiono gesti che allarmano, e vengono trattate come un problema di sicurezza. Nessuna forza di polizia è attrezzata per affrontare il disagio mentale. Quando ci prova, spesso lo fa con strumenti violenti: taser, armi da fuoco, contenzione. A volte con esiti mortali. Ancora una volta, la repressione sostituisce la cura.
Poi ci sono i conflitti quotidiani: litigi tra vicini, tensioni condominiali, alterchi banali che degenerano. L’aumento delle chiamate al 112 non è segno di maggiore criminalità, ma di una crisi profonda della mediazione sociale, della convivialità, della capacità di risolvere pacificamente i conflitti. Dove sono finiti i mediatori sociali? Dove sono i luoghi della socialità? Al loro posto, il riflesso condizionato di chiamare la polizia per qualsiasi problema.
Anche questo è il risultato di un clima culturale preciso, alimentato da politica e media: “tolleranza zero”, “più repressione”, “più polizia”. Un incitamento permanente al ricorso alle forze dell’ordine, che fa la fortuna degli imprenditori del sicuritarismo ma impoverisce le città.
La vera sicurezza nasce dal rilancio della socialità, della vita associativa, della cooperazione tra residenti. Servono animatori sociali formati, non iniziative estemporanee di facciata. Serve ricostruire luoghi, relazioni, fiducia. È lì che si costruisce una cultura della prevenzione: contro le dipendenze, il disagio psichico, lo sfruttamento lavorativo, l’inquinamento, il degrado urbano, l’abbandono degli spazi pubblici.
La sicurezza non si produce accumulando divise e telecamere. Si produce riducendo le cause del malessere. Continuare a inseguire una sicurezza tutta poliziesca significa rinunciare a governare la complessità delle città e scegliere la scorciatoia repressiva. Una scorciatoia che non risolve nulla e prepara solo città più fragili, più impaurite, più diseguali.
Se i sindaci vogliono davvero città più sicure, devono avere il coraggio di dirlo chiaramente: senza prevenzione, senza welfare territoriale, senza socialità e cooperazione, la sicurezza resta solo uno slogan. E uno slogan, per di più, pericoloso.
*coordinatore Osservatorio Repressione