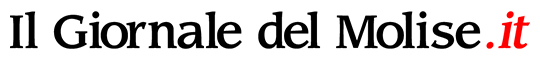di Italo Di Sabato*
Quello che inquieta davvero, in ciò che sta accadendo attorno al Venezuela, non è soltanto il destino di un paese latinoamericano già duramente provato. È qualcosa che riguarda direttamente anche noi: il modo in cui definiamo oggi la democrazia, chi ha diritto di rappresentarla e chi può essere legittimamente rimosso dal consesso internazionale senza troppe domande. Se finiamo per accettare il diktat di Donald Trump, lodandolo apertamente o incassandolo in silenzio come fatto compiuto, allora il problema non è più Caracas, ma Bruxelles, Roma, Berlino. È la nostra idea di sovranità popolare a entrare in crisi.
Il punto non è assolvere Nicolás Maduro. Il punto è il criterio con cui si stabilisce chi è democratico e chi no. Se passa l’idea che Maduro sia una minaccia globale tale da giustificarne la rimozione forzata, per poi affidare il futuro del paese a quella stessa destra che nel 2002 partecipò al golpe contro Hugo Chávez, allora stiamo normalizzando un principio pericolosissimo: la democrazia come concessione selettiva, revocabile quando non allineata agli equilibri geopolitici dominanti.
Il golpe del 2002 e la democrazia che non si volle vedere
Del colpo di Stato del 2002 si parla sempre meno, eppure è impossibile capire il Venezuela senza ricordarlo. Chávez era stato eletto democraticamente da poco più di un anno quando venne arrestato nel palazzo di Miraflores. Le immagini di quei giorni – raccolte in uno straordinario documentario britannico – mostrano con chiarezza chi fossero i golpisti: settori della grande impresa, burocrazie consolidate, sindacalisti corrotti, alte gerarchie ecclesiastiche, ambasciatori occidentali, borghesia elegante e sicura di sé.

Caracas, capitale dell’altermondialismo dimenticato
Nei primi anni Duemila, Caracas non era un’anomalia autoritaria, ma uno dei laboratori politici più osservati del Sud globale. Erano gli anni di World Social Forum di Porto Alegre, del movimento no global, di un dialogo intenso tra governi progressisti e movimenti sociali. In quei contesti incontrare Chávez o Evo Morales era normale. Si discuteva di democrazia partecipativa, di redistribuzione, di sovranità popolare.
La rivoluzione bolivariana aveva scelto una strada precisa: investire massicciamente sul capitale umano. Le misiones portarono alfabetizzazione, sanità di base, medici nei ranchos, cibo sovvenzionato, documenti d’identità a milioni di persone che prima erano semplicemente invisibili. In quartieri come Petare, 23 de Enero, Catia o La Vega, lo Stato arrivò per la prima volta nella vita concreta degli abitanti.
Due Caracas, due memorie
Qui sta una delle chiavi che spesso mancano nel racconto europeo. Il Venezuela è attraversato da una frattura sociale profondissima, che è anche geografica e simbolica. Nei quartieri popolari, il chavismo non è stato solo un governo, ma il primo riconoscimento di esistenza sociale. Nei quartieri medio-alti – Altamira, Chacao, Las Mercedes – Chávez e poi Maduro sono stati vissuti come una rottura traumatica di un ordine che li vedeva al centro.
Queste due memorie non si parlano. Per questo è fuorviante ridurre tutto alla formula rassicurante: “è caduta una dittatura”. È vero: sotto Maduro c’è stata una deriva autoritaria, con l’uso eccessivo di decreti, arresti illegittimi, restrizioni gravi. Ma è altrettanto vero che esiste ancora un appoggio popolare reale, di massa, nei barrios. La cattura di Maduro, per molti tra i più poveri, non è percepita come la fine di un regime, ma come un attacco a un intero mondo sociale.
L’embargo: la guerra che non si vuole nominare
C’è poi un elemento sistematicamente rimosso: l’embargo statunitense. Un paese ricchissimo di petrolio ma con una struttura economica fragile è stato colpito su ciò che garantisce la sopravvivenza: cibo e medicinali. L’embargo sui farmaci è stato particolarmente devastante. Una ONG americana ha stimato in decine di migliaia le morti evitabili causate dalla mancanza di medicinali. Questa strozzatura – analoga a quella imposta da decenni a Cuba – ha alimentato criminalità, corruzione, emigrazione di massa.
È dentro questa guerra non dichiarata che vanno letti anche molti errori di Maduro: errori gravi, certo, di un leader inadeguato a una crisi di tale portata. Ma giustificare un rapimento o una rimozione forzata ignorando il contesto significa accettare una narrazione mutilata.
Il peccato imperdonabile: un’altra integrazione possibile
Chávez stesso riconobbe i limiti del suo progetto: non essere riuscito ad avviare per tempo una vera diversificazione economica. Ma la sostanza di un disegno strategico esisteva ed era ciò che spaventava Washington: l’idea di un’integrazione latinoamericana autonoma, lanciata simbolicamente a Cuzco, capace di creare un mercato comune fondato su una storia condivisa di colonizzazione e resistenza. Come scrisse Theotonio dos Santos , un progetto potenzialmente più solido dell’Unione Europea perché radicato in un’identità storica comune. È questo il vero “peccato” che gli Stati Uniti non hanno mai perdonato al Venezuela bolivariano.
Razza, classe e potere: la ferita simbolica
C’è infine una dimensione che in Europa si fatica a vedere: quella razziale e simbolica. Chávez fu il primo presidente venezuelano moderno apertamente non bianco; Maduro proviene dallo stesso mondo popolare. In un paese storicamente governato da élite bianche o “blanqueadas”, questo ha rappresentato una rottura profonda. Per molti è stata una rivincita simbolica; per altri, una perdita insopportabile. Anche questo spiega l’intensità dello scontro, l’odio e la fedeltà.
Capire non significa assolvere
Il Venezuela non è leggibile con categorie semplici. È un paese attraversato da fratture storiche di classe, razza e memoria. Capire tutto questo non significa giustificare le violazioni, né assolvere Maduro. Significa però rifiutare la semplificazione che ci rende più comodi e meno responsabili. Prima di dichiarare chiusa una storia, bisognerebbe almeno ricordare che, per milioni di persone, quella storia è tutt’altro che finita.
*Attivista sociale, coordinatore dell’Osservatorio Repressione. È stato dirigente politico di Democrazia Proletaria e Rifondazione Comunista, nonché consigliere regionale in Molise.