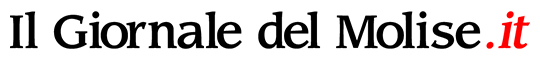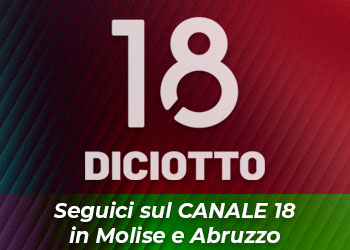di Italo Di Sabato*
L’Italia da anni vive dentro un paradosso che è ormai diventato la sua cifra politica e culturale: più la società si impoverisce, più cresce la domanda di sicurezza. È un automatismo che non nasce dal caso, ma da una precisa dinamica economica e sociale. Le persone che vivono nella precarietà, schiacciate da salari bassi, servizi carenti, vita instabile, si sentono più esposte, più fragili, più sole. La paura, in un tale contesto, non è un’emozione: è un prodotto sociale, quasi un sottoprodotto dell’austerità, dell’erosione del welfare, della cancellazione dei diritti.
Eppure, invece di affrontare le cause strutturali dell’insicurezza – la precarietà del lavoro, le disuguaglianze crescenti, la desertificazione dei servizi pubblici, la povertà abitativa – la politica ha scelto per anni la scorciatoia più redditizia: trasformare la paura in consenso. Il centrodestra ha fatto di questo meccanismo un’arte, costruendo su di esso un’egemonia culturale che oggi appare quasi inscalfibile. Gli basta sollevare il tema della sicurezza, agganciarsi a un fatto di cronaca qualsiasi, amplificarlo fino alla distorsione, e usarlo per dipingere un Paese invivibile, assediato da nemici interni ed esterni.

È un copione che conosciamo bene: paura → audience → consenso. Una catena che si autoalimenta e che non richiede soluzioni, solo narrazioni. Non importa che i reati siano in calo: ciò che conta è la percezione, che può essere manipolata con estrema facilità. La destra rende il Paese più impaurito, e un Paese impaurito vota per chi promette ordine, disciplina, repressione. Una macchina perfetta, che produce insicurezza per poi venderne la cura.
Il centrosinistra, di fronte a questa strategia, non solo è apparso incapace di proporre un discorso alternativo, ma spesso si è consegnato alla logica dell’avversario. Diviso, litigioso, ripiegato su ambiguità e tatticismi, ha rinunciato a imporre un tema che parli ai bisogni materiali del Paese: lavoro, casa, cure, istruzione, diritti. Ha inseguito la destra sul terreno della sicurezza, accettandone le categorie, adottandone persino la lingua. Così facendo, ha contribuito a legittimare un immaginario sicuritario che è esattamente ciò che blocca ogni possibilità di cambiamento. Il risultato? L’Italia rimane imbrigliata in una doppia assenza: assenza di welfare e assenza di alternativa.
Ma nel frattempo, qualcosa di più profondo è cambiato. Siamo di fronte a una mutazione antropologico-cognitiva che ha riscritto le fondamenta del discorso pubblico. L’uguaglianza, per anni pilastro della cultura politica italiana, è stata sostituita dalla legalità. La giustizia sociale è stata rimpiazzata dal giustizialismo. Il conflitto sui diritti e sulle risorse è stato cancellato e sostituito dal conflitto identitario, dal linciaggio morale, dalla caccia al colpevole. La cronaca nera è diventata il principale prisma attraverso cui osserviamo noi stessi. Tutti si percepiscono “giusti”, e i “colpevoli” sono sempre gli altri: i poveri, i migranti, i giovani, i marginali, chi non può difendersi.
La logica del capro espiatorio domina la scena. Si invoca la gogna, il processo mediatico, la punizione esemplare. È un rito collettivo che non risolve, non spiega, non approfondisce. Serve solo a canalizzare la rabbia di un Paese sempre più impoverito contro bersagli facili, distogliendo lo sguardo da chi quella rabbia la produce. Basta salire su un treno, ascoltare le conversazioni, leggere i commenti sui social: ovunque si respira risentimento, sospetto, incattivimento. Non è un tratto caratteriale: è il risultato politico di un impoverimento materiale e simbolico che dura da decenni.
Su questo terreno il governo Meloni ha costruito la propria identità. La risposta è sempre la stessa: più forze dell’ordine, più controlli, più repressione. Ogni fragilità sociale diventa devianza, ogni disagio diventa minaccia. La sicurezza non è una politica, ma un dispositivo ideologico: serve a giustificare misure eccezionali, a spostare il discorso pubblico, a disciplinare i corpi e le menti. Perfino la scuola, luogo per eccellenza del pensiero critico, viene inglobata nel paradigma sicuritario: presidi di polizia, lezioni sul rispetto dell’autorità, punizioni esemplari. Ma una scuola che educa alla paura e all’obbedienza non è più scuola: è il preludio culturale dell’autoritarismo.
Eppure i numeri raccontano un’altra storia. L’Italia è oggi il Paese europeo che, in proporzione, spende di più per la sicurezza pubblica e privata. Abbiamo un apparato sicuritario ipertrofico, che cresce mentre il welfare arretra. E tuttavia nessuno – né governo né opposizione – ha mai avviato una valutazione seria dell’efficacia degli strumenti utilizzati. Ad esempio per le politiche migratorie: l’80% dei fondi destinati ai migranti viene speso in misure di repressione, solo il 20% in integrazione, formazione, sostegno. È un modello fallimentare che produce marginalità anziché ridurla. Ma funziona benissimo come propaganda.
Intanto, la spesa sociale italiana è sotto la media europea di due punti e mezzo di Pil. Il sottofinanziamento è evidente ovunque: politiche abitative inesistenti, sostegno al reddito insufficiente, servizi per i non autosufficienti drammaticamente carenti. È qui che nasce la vera insicurezza: nella solitudine dei lavoratori poveri, delle famiglie senza casa, degli anziani abbandonati, dei giovani senza prospettive.
Eppure nessuno ha il coraggio di dirlo. Perché parlare di welfare, di diritti sociali, di redistribuzione significa spostare l’attenzione dal nemico inventato al nemico reale: un modello economico che genera precarietà e un paradigma politico che la trasforma in paura.
Invertire questo ordine del discorso è un’urgenza democratica. Significa affermare che la sicurezza non è il contrario della libertà, ma della disuguaglianza. Significa dire che l’Italia non è più povera perché “invasa”, ma perché sfruttata. Che non è più insicura perché ci sono “troppi giovani fuori controllo”, ma perché non ha case, scuole, sanità, salari adeguati. Che la repressione non è una politica, ma una rinuncia alla politica.
 Ricostruire un immaginario alternativo significa rimettere al centro ciò che tiene insieme una società: la cura, il lavoro, la dignità, i servizi pubblici, la solidarietà. Significa dire chiaramente che la sicurezza reale – quella che cambia la vita delle persone – nasce da un welfare forte, non da uno Stato armato. Nasce da case accessibili, da salari dignitosi, da scuole libere, da quartieri vivi.
Ricostruire un immaginario alternativo significa rimettere al centro ciò che tiene insieme una società: la cura, il lavoro, la dignità, i servizi pubblici, la solidarietà. Significa dire chiaramente che la sicurezza reale – quella che cambia la vita delle persone – nasce da un welfare forte, non da uno Stato armato. Nasce da case accessibili, da salari dignitosi, da scuole libere, da quartieri vivi.
L’Italia non è condannata all’incattivimento. Ma per invertire la rotta serve un atto di coraggio politico: rompere la liturgia della paura, smontare la retorica tossica della legalità come surrogato dell’uguaglianza, rifiutare l’idea che il controllo sia la risposta universale ai problemi del Paese. Serve ricostruire un movimento culturale e politico capace di dire che un’altra Italia non solo è possibile, ma è necessaria.
Una politica che protegge invece di punire, che crea orizzonti anziché fantasmi, che non alimenta l’emergenza ma rivendica il futuro: è da qui che bisogna ripartire. Il resto è solo gestione del declino.
*coordinatore Osservatorio Repressione