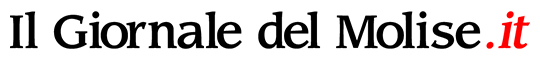Se militarizzano la società e ci chiamano nemici, la risposta è una sola: disertare la loro guerra, sottrarsi alla paura, spezzare il linguaggio che la legittima, difendere lo spazio vivo del dissenso.
di Italo Di Sabato*
Ci stanno preparando alla guerra. Non è retorica, non è uno slogan da corteo: è il progetto che prende forma mentre veniamo immersi in un clima di emergenza permanente. La parola emergenza è diventata la chiave che apre ogni porta, giustifica ogni restringimento, trasforma ogni necessità di controllo in un atto inevitabile. È attraverso questa logica che si costruisce il vero campo di battaglia: non ai confini, ma dentro la società.
![]() Perché l’emergenza non è mai neutrale. Quando diventa permanente, smette di essere un’eccezione: diventa un regime. E un regime di eccezione è sempre, nella sostanza, uno stato di guerra.
Perché l’emergenza non è mai neutrale. Quando diventa permanente, smette di essere un’eccezione: diventa un regime. E un regime di eccezione è sempre, nella sostanza, uno stato di guerra.
Il riarmo corre, le spese militari crescono come se il futuro fosse già deciso. Gli apparati di sicurezza si espandono mentre lo spazio dei diritti si restringe. E nel frattempo, il dissenso — qualsiasi forma di dissenso — viene trattato come un’anomalia da criminalizzare o reprimere. Non perché minacci il Paese, ma perché minaccia l’obbedienza che lo stato di eccezione richiede per sopravvivere.

La retorica è identica a quella di ogni conflitto: emergenza, minaccia, ordine pubblico. Sono parole che non descrivono la realtà: la disciplinano. La piegano. La preparano.
In questo teatro, il “nemico interno” viene costruito con una cura minuziosa: decreto dopo decreto, ordinanza dopo ordinanza, ridefinendo la protesta come rischio, la critica come disturbo, la piazza come zona rossa. L’Europa che prometteva diritti ora investe in blindati; i governi che avrebbero dovuto ascoltare ora rispondono con scudi e caschi; la democrazia, che vive del conflitto delle idee, pretende disciplina e silenzio.
Ma non basta dire no alla guerra. Serve qualcosa di più radicale: serve disertarla.
Disertarla fisicamente, rivendicando l’obiezione di coscienza e rifiutando che i corpi dei cittadini vengano assorbiti in un clima che normalizza la logica del conflitto. Disertarla politicamente, sottraendosi allo stato di eccezione che viene imposto come destino. Disertarla lessicalmente, perché ogni guerra inizia dal linguaggio: dalle metafore militari usate per descrivere la società, dalle parole che trasformano il dissenso in minaccia e l’ordine in necessità.
Perché quando il linguaggio della guerra conquista il discorso pubblico, il passo successivo è che la guerra conquisti la vita quotidiana. E quando la vita quotidiana viene militarizzata, la democrazia non è più un sistema di diritti: è un campo da presidiare.
Lo chiamano sicurezza. Ma sicurezza non è. È un progetto di militarizzazione sociale, lento e profondo.
La scelta, oggi, è semplice e drammatica: o ricostruiamo lo spazio sociale del dissenso, rompendo la gabbia dell’emergenza permanente, oppure ci ritroveremo a vivere in un continente che ha fatto della paura il proprio statuto e della guerra la propria normalità.
La vera minaccia non è un nemico esterno, ma lo stato di eccezione che stanno normalizzando dentro ciò che un tempo chiamavamo democrazia — e che oggi somiglia sempre più a una post-democrazia disciplinare, a una democratura che pretende obbedienza invece di partecipazione. È da questo nuovo regime dell’emergenza che dobbiamo cominciare a disertare: rompendo la sua logica, il suo linguaggio, la sua pretesa di inevitabilità.
*Attivista sociale, coordinatore dell’Osservatorio Repressione. È stato dirigente politico di Democrazia Proletaria e Rifondazione Comunista, nonché consigliere regionale in Molise.