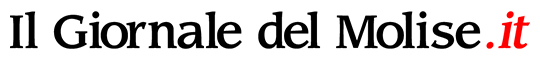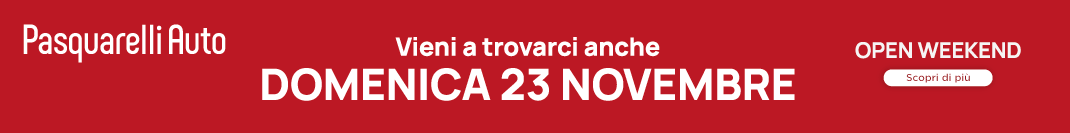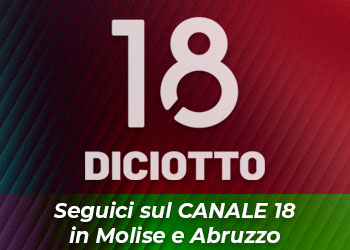Cosa significa oggi parlare della solitudine interiore, della solitudine creatrice, e della solitudine dolorosa, quella dell’isolamento e del distacco dal mondo? Come si confrontano, a loro volta, le esperienze, i modi di essere della solitudine quando la nostra vita è a un bivio o è sommersa dalla paura e dall’angoscia? Come si intrecciano l’una e altra forma e si separano nella vita di tutti i giorni, nelle esperienze del dolore, della sofferenza, della felicità perduta e della vita mistica, ma anche nel vasto e scosceso campo del vivere e del morire?
Sono questi i temi che lo psichiatra Eugenio Borgna[1] prende in esame ne La solitudine dell’anima (Feltrinelli, 2013). Un lavoro puntuale, garbato e a tratti coraggioso, per l’elogio controcorrente, in un mondo estremamente interconnesso, alla scelta di ‘stare soli’, per occuparsi temporaneamente della propria interiorità, alla ricerca di una perduta dimensione creativa. Senza perdere, per questo, la nostalgia degli altri.
Borgna invita così – ne La solitudine dell’anima – a percorrere a viso aperto gli insidiosi sentieri dei moti interiori, battendo percorsi cruciali e inediti. Lo fa, riconoscendo nella comprensione dell’Altro i benefici, e uno stimolo ancora valido per un ripensamento della figura del malato o del sofferente nella modernità liquida. Per Borgna, l’ascolto diventa lo spazio privilegiato dell’interiorità lacerata, senza il riconoscimento della quale la dignità dell’individuo non può essere rispettata. Ma il linguaggio psichiatrico da solo non può rispondere alle esigenze di un animo ferito e solitario, e questo Borgna lo sa, ed è continuo, infatti, il richiamo alla parola dei poeti (Emily Dickinson, Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Rainer Maria Rilke, Antonia Pozzi…), della speculazione filosofica ( Simone Weil, Agostino…), fino alla voce arcana del misticismo (Thérése de Lisieux, Angela da Foligno…), per giungere all’intendimento quasi empatico con l’Altro.
In questo senso Borgna riscopre la qualità della solitudine in un mondo ammaliato e oppresso dall’avvento dell’era digitale. La solitudine non è solo un’esperienza interiore di pochi eletti, ma al contrario è << una matrice ideale di cambiamento relazionale e culturale, politico e sociale, e in ultima istanza ragione di vita storicamente significativa. È indispensabile ritrovare i valori inalienabili della riflessione critica e della solidarietà, dell’impegno etico nella politica, del rispetto radicale delle persone, e delle loro differenze – trasferendo la coscienza di questi valori in quella che è l’azione quotidiana, la testimonianza personale di ciascuno di noi».
[1] È stato libero docente alla “Clinica delle malattie nervose e mentali” dell’Università di Milano ed è primario emerito di psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara. È autore di numerosi saggi, nei quali alterna una produzione più specialistica a libri maggiormente divulgativi. In qualità di esponente della psichiatria fenomenologica, contesta l’interpretazione naturalistica – ancora oggi in voga – delle patologie mentali che ricerca le cause della psicosi nel malfunzionamento dei centri cerebrali, e la sua cura attraverso i farmaci e l’elettroshock.