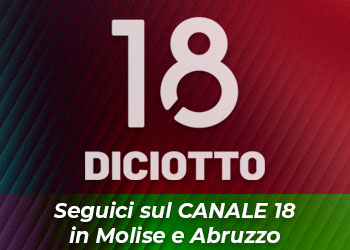di Antonio Picariello
di Antonio Picariello
Scrivo al grande Giuseppe Mammarella, UOMO DI CULTURA E DI RICERCA, PARSIMONIOSO E DELICATO che dalla sua antica formazione seminariale ha tratto l’educazione precisa e nobile di saper raccogliere conoscenza e distribuirla nell’arco della sua vita con raffinata e saggia misurazione come il sole e la luna distribuiscono l’intensità raggiera della luce al nutrimento armonico delle stagioni e della notte. Uomini di questo stampo che raccolgono un antico modello del benessere collettivo, strutturano la propria esistenza sull’avvicendarsi tra le polarità del dono e dell’avere come cristiana cattolica fede “ordina” e promuove nel movimento secolare della partecipazione alla vita. Si tratta però di un dono o undonare complesso, delicato e sacro contrapposto al concetto del possesso e dell’avarizia, peccati gravi di cui ogni epoca si è servita per comparare il “gusto” con l’ingiusto all’insegna di una linea portante che sempre teso, nei momenti di buona evoluzione, a privilegiare la vita e il bene comune come dice un classico saggio dell’antropologo Marcel Mauss dal titolo originale “Essai sur le don. Forme et raison de l’échangedanslessociétésarchaïques”-Purtroppo nell’era della digitalizzazione spietata e selvaggia questo classico dell’economia del dono comune ci riporta a riassumere e a riflettere sulla nostra perduta condizione di sapienti per il ritorno a un primitivismo inconsapevole e sciatto che manca di strumenti tradizionali e innovativi per la “possibilità di ristrutturazione” della contemporanea “qualità” della nostra vita. Il grande Giuseppe Mammarella nella sua costruzionebiografica ha saputo, come un esperto e qualificato costruttore di cattedrali, adoperare l’esclusione canonica del sapere accademico con l’invenzione di un metodo soggettivo e producente, semplice nella sua metodologia ma, efficace e comodo per un sapere alla collettività che da molti anni ha nutrito la propria identità attraverso queste moderate ricerche prevalentemente storiografiche. Il responsabile dell’Archivio Diocesano ha saputo calibrare nella distribuzione precisa delle pubblicazioni e dei convegni, a volte conferenze raramente nei dibattiti il giusto modello di trasmissione comunicativa per la pressa di coscienza, almeno una parte importante, della conoscenza collettiva. Non a caso Il grande larinese Giuseppe Mammarella, dopo una buona esistenza lavorativa al servizio della comunità nel ruolo di Agente, e nello stadio escatologico lavorativo di dirigente della Polizia Municipale larinate, ha ricevuto direttamente dal Vescovo di Roma in carica il prestigioso titolo di “Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno”. Papa G.M. è di estrema importanza per le arti (figurative) nell’universo di tutte culture presenti sul pianeta. “ Il ruolo del vescovo di Roma non doveva esaurirsi nella cura della città o del Patrimonium Petri. Con forza G. affermò il primato papale, basato sulla continuità con l’apostolato di s. Pietro, contestando al patriarca di Costantinopoli il diritto di attribuirsi il titolo di patriarca ecumenico” e qui l’arte figurativa assunse nel programma gregoriano il ruolo di un efficace e sostanziale strumento per la diffusione della fede. In due epistole indirizzate al vescovo di Marsiglia Sereno, colpevole di aver distrutto immagini sacre per impedire che i fedeli le adorassero, G. delineò per la prima volta, i tratti di quella concezione didascalica, educativa di massa che attraverso la figurazione sarebbe stata tipica e fondamentale del Medioevo occidentale per la conoscenza delle sacre scritture attraverso la pittura. (Idcircoenimpictura in Ecclesiisadhibetur, ut hi qui litterasnesciunt, saltem in parietibusvidendolegantquaelegere in codicibus non valent” – “aliud est enimpicturam adorare, aliud per picturaehistoriam quid sitadorandumaddiscere […]. Undepraecipuegentibus pro lectionepictura est”). Chiaramente detta così sembra cosa semplice e diplomatica mentre la realtà insegna di lunghe guerre fratricide tra strazi e assassini di crudele e inumana computazione. Senza San Gregorio Magno non ci sarebbe stata la Cappella Sistina e un Michelangelo pittore. Titolo potente dunque quello assunto dallo storiografo Giuseppe Mammarella. Titolo di grande responsabilità per la continuità e la difesa delle arti. Non a caso gli è stato assegnato il compito di organizzare la solenne celebrazione del VII Centenario del completamento (inaugurazione) della Concattedrale Basilica Pontificia della città di Larino, autentico “simbolo” di preziosità storica per l’arte e la cultura mondiale. È un capolavoro “d’art goth o d’argot” e gloria della regione Molise e dell’Abruzzo visto le facciate ( opera di Francesco Petrini) della chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano (1317), e del Duomo di San Pardo a Larino (1319), in buona parte si riprendono e si gemellano. D’altra parte le cattedrali gotiche sono dei veri e propri libri di pietra e tramandano straordinarie conoscenze che poche persone, a differenza delle icone figurative e degli affreschi pittorici, sono in grado di decodificare e comprendere. Giuseppe Mammarella ha dovuto organizzare tutto il mondo complesso e difficile dell’anniversario di questo mondiale patrimonio e l’invenzione di una mostra interpretativa (il dipinto della locandina è stato realizzato dalla bravissima Sofia Abalmosova) da parte degli artisti contemporanei scelti sul gusto soggettivo e che porta a riflettere quanto sia importante poter uscire dalla canonicità strutturale della professionalità militante e dare spazio alla gettata dell’interpretazione imitatoria dove il segno e il colore germinano spontaneità nuove di interessanti valori reinterpretativi e semantici della storia dell’arte. Per questo motivo ho deciso di consegnare una riflessione tra le funzione avvenute nell’arte attraverso le avanguardie storiche. È questo uno stato temporale a cui faccio personalmente riferimento come punto di cambiamento epocale che attraverso personaggi di estrema cultura e inventori di linguaggi artistici ha rivoluzionato il pensiero mondiale, la nostra visione e concetto di bellezza basilare e ha contribuito rivoluzionandola alla continuità ecumenica del diritto del dono alla qualità della vita. “Il 1892 fu un anno cruciale per Monet, ma anche per le sorti dell’Impressionismo e della pittura moderna in generale, poiché vide il pittore iniziare il monumentale ciclo delle Cattedrali di Rouen. Rouen era già all’epoca un fiorente centro commerciale ed industriale ubicato nella regione dell’Alta Normandia e dotata di un patrimonio architettonico di tutto rilievo: significativa, in tal senso, risulta la cattedrale, un’imponente costruzione gotica iniziata intorno nel 1145 e terminata nel 1250. La serie delle Cattedrali di Rouen è formata da 28 dipinti ad olio di Claude Monet realizzati tra il 1892 ed il 1894 e raffiguranti dallo stesso punto di vista ma quel che cambia sono le condizioni della luce che si riflette sulla cattedrale di Rouen, in particolare sul suo portale. Come un musicista può comporre un numero indefinito di variazioni su un tema, così Monet varia senza alcun cedimento qualitativo un tema ben noto a tutti: la Cattedrale di Rouen è uno dei più importanti monumenti gotici francesi. Proprio la celebrità del monumento, oggetto di visite turistiche, riprodotto in migliaia di fotografie, dà a Monet l’occasione di superare la banalità della cartolina illustrata che inquadra equilibratamente il soggetto; la facciata è vista obliquamente e solo in parte; le torri, i lati sfuggono alla nostra attenzione; non ce ne è mostrate né l’altezza né la larghezza; possiamo liberamente integrarla ciascuno secondo la propria sensibilità, così che da semplici spettatori ci trasformiamo in attori, diventando compartecipi della creazione, che non è statica (ossia già compiuta e perfetta), ma dinamica (ossia in divenire e perfettibile”. Ecco il mio sommesso contributo riflessivo a un argomento che sarà fondamentale per la nostra nuova storia dell’arte fatta di amore e filologia etica morale giusta forte sapiente e bella. Buo
n Lavoro. Antonio Picariello